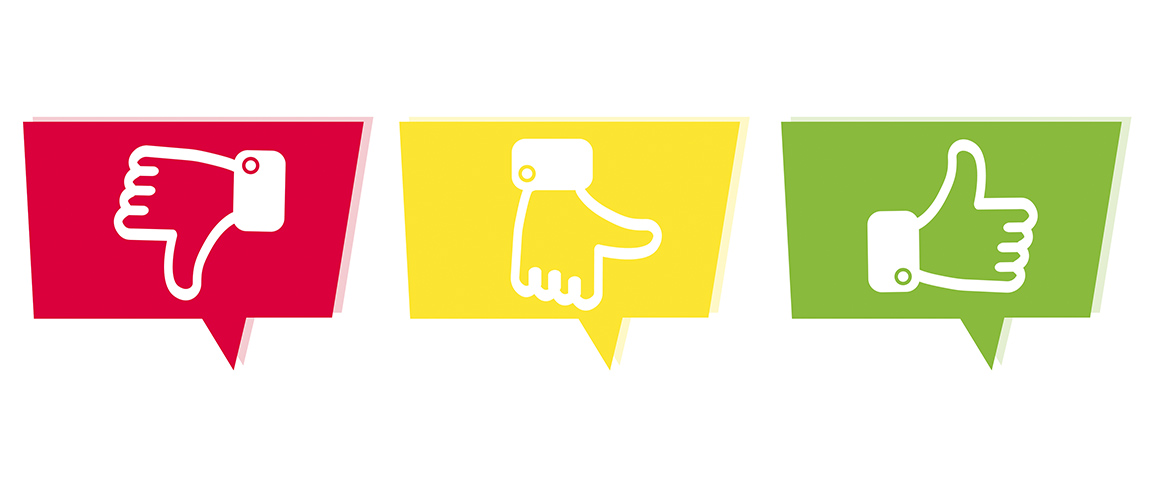di Damiano Palano*
Per molti anni, dopo il 1989, un po’ tutti abbiamo creduto che la Storia fosse finita. Non tanto perché pensassimo che non ci sarebbero stati mutamenti, innovazioni e conflitti più o meno cruenti. Quanto perché – come scrisse Hegel a proposito degli ideali della rivoluzione francese, all’indomani della vittoria di Napoleone a Jena nel 1806 – anche noi abbiamo ritenuto che la democrazia liberale avesse definitivamente sbaragliato i suoi antagonisti. E soprattutto abbiamo immaginato che i possibili mutamenti futuri avrebbero semmai potuto “migliorare” le forme della democrazia liberale, senza però metterne in questione i cardini.
Anche per questo, i politologi occidentali che per anni hanno puntualmente registrato le evoluzioni della nostra geografia elettorale, non hanno mai preso seriamente in considerazione l’idea che le «democrazie mature» fossero esposte a rischi fatali. Con una chiave di lettura più ottimista, alcuni hanno interpretato le trasformazioni seguite al crollo del blocco sovietico nei termini di un passaggio dalla democrazia dei partiti a una «democrazia del pubblico»: un assetto in cui gli elettori, liberi dai vincoli ideologici, potevano votare esprimendo la loro opinione, valutando – proprio come il pubblico di un teatro – le proposte avanzate dai vari candidati. Altri, con uno sguardo più pessimista, hanno invece rinvenuto nel calo della partecipazione politica e nella crescente sfiducia verso la classe politica e verso le istituzioni i sintomi di una crisi incipiente, o comunque di un ‘malessere’ capace di indebolire le basi della convivenza democratica. Ma in ogni caso, neppure i più pessimisti hanno rinvenuto in queste tendenze minacce davvero capaci di determinare un “crollo”, o quantomeno di ‘deconsolidare’ l’assetto dei regimi democratici.
A un certo punto il contesto è invece cambiato radicalmente e i sismografi che misurano le oscillazioni del clima di opinione hanno incominciato a impazzire. Nel 2016 – con il referendum sulla Brexit e la trionfale cavalcata elettorale di Donald Trump – il mutamento è diventato eclatante, anche se retrospettivamente si può riconoscere il punto di avvio del nuovo ciclo già nel 2008. In ogni caso, a partire da quel momento il «pubblico» delle democrazie occidentali ha assunto i tratti di una massa rancorosa, mentre la silenziosa disaffezione lamentata nei due decenni precedenti si è tramutata in ostilità verso ogni «casta» e in rumorosa insofferenza verso l’establishment. Per dare un nome a questa esplosione di risentimento molti hanno estratto dalla “cassetta degli attrezzi” delle scienze sociali il concetto di «populismo».
Così è diventato un luogo comune dire che siamo dinanzi a una rivolta del «popolo» contro l’establishment, o – come ha scritto per esempio Alessandro Baricco alcuni mesi fa – che stiamo assistendo alle conseguenze della rottura del «patto» tra il popolo e le élite, su cui le democrazie mature si sarebbero fondate per settant’anni. E qualcuno si è anche spinto a sostenere che la linea di divisione tra «alto» e «basso» avrebbe ormai sostituito – forse persino in via definitiva – la vecchia linea di demarcazione tra destra e sinistra, irrimediabilmente consegnata al passato. Ma chi utilizza la nozione di «populismo» spesso finisce col farne un uso piuttosto disinvolto, talvolta adoperandolo come una vera e propria clava ideologica, e in ogni caso senza avvedersi (quasi mai) delle distorsioni che si nascondono in quella nozione.
Adottando questo schema interpretativo si rischia però di replicare quella stessa logica semplificatrice, rozza, manichea, che viene rimproverata ai «populisti», e cioè di attribuire a questi “nemici” della democrazia liberale qualcosa che, a ben guardare, è un tratto costitutivo dello stesso progetto democratico occidentale.
Forse per capire davvero cosa c’è dietro la “rivolta” del popolo contro le élite dovremmo invece mettere da parte – o usare con cautela – il concetto di «populismo». E dovremmo mettere in questione quella chiave di lettura che vede nel presente la rivolta del «popolo» rabbioso, ignorante, brutale, contro le «élite». Interrogandoci un po’ più seriamente sulle radici profonde di un mutamento che investe – non da oggi – gli immaginari politici, le organizzazioni, gli stili di partecipazione, la crescita della polarizzazione. Perché probabilmente la Storia è davvero ricominciata. Ma molto di quello che ci appare “nuovo” è forse solo qualcosa che avevamo dimenticato.
* Direttore del Dipartimento di Scienze politiche