La letteratura, di qualunque genere, è un atto di giustizia, perché è sempre un “rendimento di conti”, come d’altronde emerge chiaramente anche dal termine “racconto”. Per questo motivo, come diceva Celine, la letteratura è come un “verbale di polizia”. Pertanto, leggere un libro significa prima di tutto cercare di fare propria la domanda che l’opera si pone. La questione centrale nei romanzi di Cormac McCarthy, dibattuta nel terzo incontro del Ciclo seminariale “Giustizia e Letteratura”, è la democrazia americana e il suo fondamento.
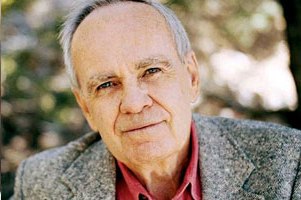 Alexis de Tocqueville, in una lettera del 1831, sosteneva che l’America fosse una società senza radici comuni e senza memoria: più felice forse di quella europea, certo non più virtuosa. Il legame sociale sarebbe quindi il solo interesse. L’opera di McCarthy è come se partisse da questa riflessione, concentrandosi sui rapporti tra individuo, comunità e legge nella società americana. In Cavalli selvaggi, primo romanzo della Trilogia della frontiera, e soprattutto dal dialogo tra John Grady e il giudice, emerge chiaramente che la legge esista, ma per funzionare vi è necessità di comunità, cioè che tutti i consociati condividano valori comuni. La figura di un altro giudice è centrale anche in Meridiano di sangue. A differenza che in Cavalli selvaggi, però, in Meridiano di sangue, la figura del giudice pare essere simbolo ed espressione del male, immanente e perpetuo nella società. Per il giudice Holden nel rituale del mondo è necessaria la guerra. La violenza è l’elemento che lega gli uomini tra loro, che li allontana dal vuoto e dalla disperazione. La comunità è dunque solamente un espediente per la creazione di un nemico comune, un modo per rispondere al caos della vita.
Alexis de Tocqueville, in una lettera del 1831, sosteneva che l’America fosse una società senza radici comuni e senza memoria: più felice forse di quella europea, certo non più virtuosa. Il legame sociale sarebbe quindi il solo interesse. L’opera di McCarthy è come se partisse da questa riflessione, concentrandosi sui rapporti tra individuo, comunità e legge nella società americana. In Cavalli selvaggi, primo romanzo della Trilogia della frontiera, e soprattutto dal dialogo tra John Grady e il giudice, emerge chiaramente che la legge esista, ma per funzionare vi è necessità di comunità, cioè che tutti i consociati condividano valori comuni. La figura di un altro giudice è centrale anche in Meridiano di sangue. A differenza che in Cavalli selvaggi, però, in Meridiano di sangue, la figura del giudice pare essere simbolo ed espressione del male, immanente e perpetuo nella società. Per il giudice Holden nel rituale del mondo è necessaria la guerra. La violenza è l’elemento che lega gli uomini tra loro, che li allontana dal vuoto e dalla disperazione. La comunità è dunque solamente un espediente per la creazione di un nemico comune, un modo per rispondere al caos della vita.
La disillusione pare permeare anche Non è un paese per vecchi, dove lo sceriffo Bell vuole dimettersi, perché non riesce a catturare un malvivente diverso da tutti quelli in cui si è imbattuto nella sua vita. Prima riusciva quasi sempre a catturare i criminali, perché si trovava di fronte a persone che pensavano come lui; invece questo criminale è un uomo che ha sì un pensiero, ma completamente alieno da quello dello sceriffo. La sconfitta dell’illusione che sia possibile fondare una giustizia sull’idea di comunità, non è, però, definitiva.
Nelle pagine finali dell’opera, da leggersi come metafora della vita dell’uomo, lo sceriffo si sofferma a guardare un abbeveratoio di pietra, scolpito da un ignoto vissuto in una società che non ha mai avuto periodi di pace, anzi che è sempre stata tormentata dalla guerra e caratterizzata dal caos dell’esistenza. Eppure quell’uomo ha trovato il tempo per scolpire un semplice abbeveratoio che durerà nel tempo e che supererà le guerre e l’incertezza della condizione umana. È come se alla disillusione si contrapponessero l’insopprimibilità della domanda e la tenacia umana volte alla ricerca della giustizia.
Ogni individuo pare così portare una “promessa dentro al cuore”. Non è quindi l’interesse e neppure il bisogno di un nemico comune a essere il vero fondamento del rapporto tra uomo, cittadino e giustizia, ma una dimensione antropologica, una sorta di promessa, forse di carattere religioso, che permette di affrontare il tempo e il caos con un progetto abbastanza lungo da rendere possibile un’ipotesi di giustizia, di rispetto della giustizia, di condivisione e di comunità.
Il ciclo proseguirà con due tavole rotonde: il 13 marzo 2014, sulla necessità della letteratura nella scienza giuridica, e il 10 aprile 2014, in tema di responsabilità medica, medicina difensiva e medicina narrativa.

