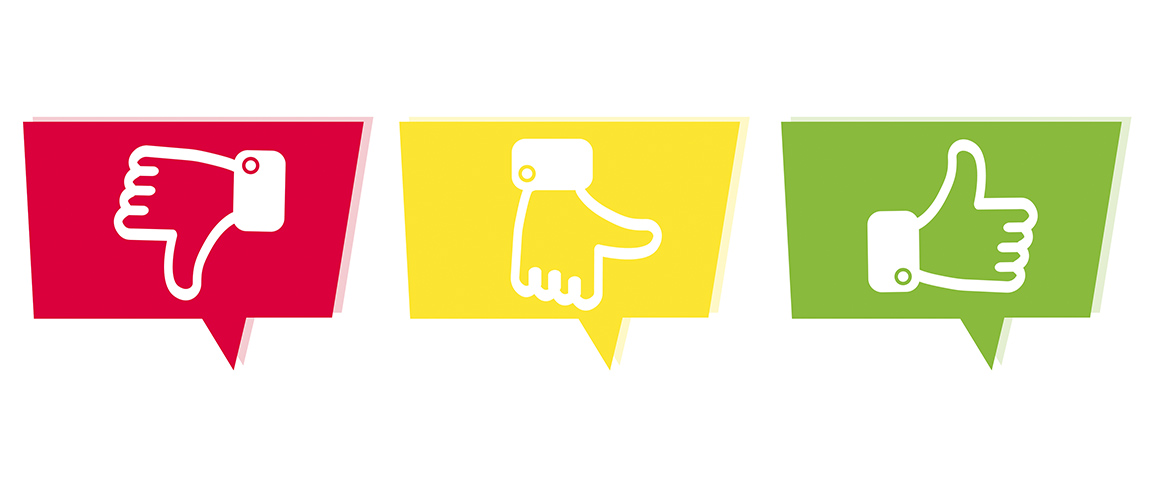di Lorenzo Fossati *
Tra i non troppi filosofi cui è capitato di non essere noti ai soli specialisti ma di entrare a far parte del patrimonio culturale comune, che ovviamente attribuisce loro idee più bislacche o intuizioni più folgoranti di quanto in effetti non siano state, figura senz’altro Jean-Jacques Rousseau, il cui nome – se non proprio il pensiero – fa parte da qualche tempo addirittura della nostra quotidianità politica.
Visse nel Settecento, nacque in Svizzera e girovagò per l’Europa, le sue opere furono influenti e dibattute, entusiasticamente esaltate o ferocemente contrastate, e certamente la sua figura è a buon diritto un simbolo di quella «modernità» e di quell’«illuminismo» che avrebbero sovvertito un ordine delle cose ormai secolare, contribuendo a creare quello che tuttora è il nostro orizzonte spirituale e sociale.
Volendo appunto evocare la sua visione, provando a farla riemergere dal patrimonio sedimentato in ciascuno, andrebbe innanzitutto richiamato il concetto di «volontà popolare», l’autentica e legittima fonte del potere e del diritto, cui si è sostituita quella del sovrano: i re sono insomma usurpatori e sovvertitori di un ordine naturale che di per sé sarebbe buono, ma che la storia e la civiltà hanno corrotto. Non siamo dunque noi i sovversivi che vogliono ribaltare le regole della società umana: è invece questa a essersi messa a testa in giù… e si tratta di raddrizzarla. La natura è fondamentalmente buona ed è la civiltà a essere sbagliata: correggerne le storture significa quindi ristabilire l’ordine autentico delle cose, liberando l’uomo da quel che l’opprime non solo nel senso di un potere più o meno assoluto che lo assoggetta, ma anche di tutte le zavorre e i lacci che gli impediscono di esprimere e realizzare pienamente se stesso.
Gli importanti contributi alla politica e alla pedagogia di Rousseau (andrebbe almeno ricordato il 1762, anno in cui uscirono il Contratto sociale e l’Emilio) attingono a una concezione dell’uomo intrinsecamente ottimistica, che alimenta veri e propri miti, come quello del «progresso», non per forza ineluttabile ma sicuramente conseguibile, o quello del «buon selvaggio», in base al rapporto inversamente proporzionale tra naturalità e civilizzazione.
Il termine «mito» non deve necessariamente essere inteso in senso deteriore. È vero, ora guardiamo alle idee di Rousseau con maggiore criticità e consapevolezza, se non con scetticismo e una punta di accondiscendenza: si tratterebbe appunto di miti che oggi possiamo riconoscere nella loro velleitaria artificialità e unilaterale inadeguatezza, divertendoci a smontarli proprio come essi a suo tempo servirono per smontare l’impalcatura concettuale precedente. Insomma, prima o poi siamo tutti parricidi o regicidi. Ma d’altra parte ogni rivoluzione avviene in base a ideali e costellazioni che si intendono come più adeguate o vere, insomma migliori, che sono di fatto «miti» nuovi, fondatori di una nuova epoca e di un nuovo mondo, e ci sarà poi tempo per affinare e rettificare la mira o, finalmente, per decostruire e smantellare l’edificio, per edificare una casa che ci parrà migliore.
Da questo punto di vista più neutrale, non solo alcune potenti ispirazioni di Rousseau sono diventate «miti», ma la stessa sorte è toccata a lui stesso, divenuto l’eroe eponimo della «democrazia diretta» che dà il nome alla «piattaforma» a tutti nota. Abbiamo bisogno di simboli e totem da evocare e riconoscere in modo da rendere immediatamente chiaro a noi stessi quel che stiamo facendo e perché, e – al di là di quel che sappiamo o ricordiamo di un tormentato intellettuale ginevrino nato trecento anni fa – quel che conta è ciò che rappresenta idealmente, sia come esplicito vessillo da esibire in modo identitario, sia come inconsapevole sedimento culturale condiviso: la lotta ai tiranni usurpatori e sovvertitori dello stato di natura (loro), la pace e la libertà da ristabilirsi fra i buoni e giusti (noi).
È troppo facile vincere una disputa affermando che «la situazione è un po’ più complessa»: le cose sono sempre più ricche e complicate di quel che riusciamo a capirne, quindi l’obiezione deve sforzarsi di essere pertinente e articolata. Incrinare le certezze di Rousseau e distruggerne i miti (o il mito) non è difficile, anche grazie al cammino percorso sulla strada da lui tracciata: a titolo d’esempio può bastare ricordare come egli abbia abbandonato in orfanotrofio i propri figli, come la volontà generale si trasformi nella «furia del terrore» (Hegel dixit) o quanta sorprendente misoginia pervada molte sue pagine (suscitando l’indignazione della prima femminista della storia, Mary Wollstonecraft, tra l’altro – a proposito di miti – madre dell’autrice di Frankenstein, il moderno Prometeo). Meno scontato è però individuare con sicurezza ciò da cui questi miti scaturiscono, l’esigenza cui rispondono o aspirano a rispondere; tuttavia solo così si può sperare di elaborare una risposta diversa e alternativa, se quei miti non ci soddisfano.
Con buona pace delle semplificazioni storiografiche e dell’universale rimpianto dei bei tempi che furono, non esiste epoca storica che non sia stata tormentata e «di passaggio», anche se ovviamente ciascuno interpreta la propria come un unicum (come del resto la propria biografia, incomparabilmente più interessante di quella altrui). Pur con questo caveat sembra proprio che i nostri tempi siano «molto interessanti» da più punti di vista (e non è un pregio): l’aspirazione alla felicità e al benessere, la speranza in un mondo migliore, stanno cercando forme nuove per esprimersi e concretizzarsi. Se non ci convincono le risposte di Rousseau o di coloro che vi si richiamano (o pretendono di farlo), cerchiamo di porci questioni radicali: davvero l’uomo è buono per natura? davvero ciascuno di noi è sempre il miglior giudice dei propri affari? davvero il consenso è un criterio affidabile? Le risposte non sono scontate né semplici, come si spera sia evidente, ma è affrontando tali faccende che si può sperare di capire che cosa non ha funzionato (perché qualcosa non sta funzionando, e non da oggi) e come si può cercare di sistemare le cose (perché su questo senz’altro vale la pena scommettere, che le cose possano migliorare).
In effetti, voler dare risposte semplici a problemi complessi, questo sì che pare un tratto distintivo del nostro tempo. È un errore che Jean-Jacques Rousseau – l’uomo e non il mito, a suo tempo e per quel che poté – non ha mai commesso.
* docente di Storia della filosofia, facoltà di Scienze della formazione, Università Cattolica, campus di Milano