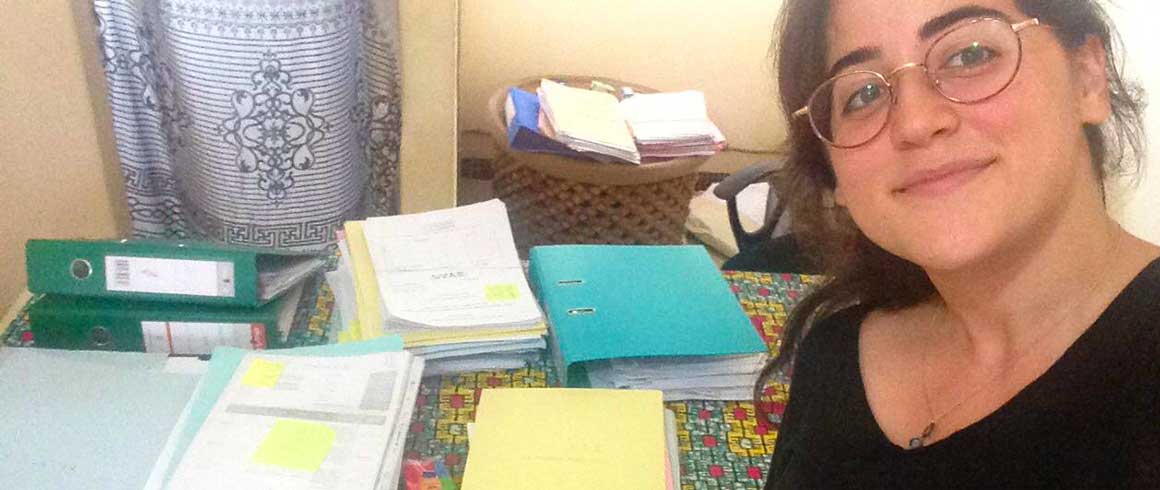di Clara Lomonaco *
Sin dal mio arrivo in Africa ho subito preso coscienza di una realtà in cui la teoria e la pratica non sempre riescono a coincidere. La cooperazione è un ambiente difficile da comprendere, per la sua natura così internazionale, le sue continue contraddizioni e i soggetti che ne fanno parte; per lavorare in questo mondo è necessario non dare nulla per scontato, imparare a costruire partendo dalle fondamenta, trovare compromessi e “vie di mezzo”, abbracciare il diverso in tutti i suoi aspetti.
Il mio compito, per due mesi, sarà di immergermi al 100% nella realtà di una Ong che lavora in Senegal dal 2015, il Vis – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Il progetto che questa organizzazione porta avanti, da ormai un anno, si chiama “Vivre et reussir chez moi” e ha sede in due città senegalesi fortemente colpite dal fenomeno dell’immigrazione irregolare, soprattutto tra i giovani. È proprio a questi ultimi che il progetto si indirizza, con l’obiettivo di trasmettere loro l’idea che possano avere successo anche in Senegal senza dover sostenere un viaggio a occhi chiusi e rischioso per cercare fortuna altrove.
Leggendo i vari documenti che mi sono stati mandati prima della partenza (per non arrivare impreparata), mi sono detta: “È davvero una bella sfida ma non mi sembra così difficile, d’altronde tutti sanno che nel Mediterraneo si muore, nessuno sarebbe in grado di partire sapendo ciò!”. Quanto mi sbagliavo!
La realtà è ben diversa da ciò che pensavo. Molto spesso chi decide di partire non è la persona che fisicamente intraprende il viaggio, ma la sua famiglia. L’Europa è il sogno di una vita e poco importa se questa è messa a rischio, l’importante è che qualcuno arrivi, trovi un lavoro e mantenga il piccolo villaggio senegalese che vive al riparo dalle onde del Mediterraneo e dai suoi trafficanti di vite umane.
Come può un padre chiedere a un figlio di morire per il bene della famiglia? E come può una madre rimanere a guardare rassegnata e baciarlo, forse, per l’ultima volta? Ma in tutto questo un senso logico c’è e ci viene spiegato dalle numerose statistiche, ormai, accessibili a tutti: la maggior parte della ricchezza del Paese poggia le basi sulle rimesse, ossia, i trasferimenti di denaro da parte di quei pochi ragazzi che ce l’hanno fatta e sono arrivati sulle coste europee.
Il fenomeno della migrazione irregolare, purtroppo, non è tipico solo del Senegal ma di tutta la zona dell’Africa Occidentale, la più povera al mondo. A fronte di ciò, l’opinione del VIS è che la riduzione di questo fenomeno e del traffico di esseri umani debba partire dai paesi d’origine. Poiché la maggior parte dei migranti irregolari fugge dalla povertà e dalla mancanza di opportunità, per ridurre i flussi in uscita è importante agire su questi elementi attraverso il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle comunità locali. La partenza non può e non dev’essere l’unica scelta possibile e il VIS si impegna a fondo per trasmettere questo messaggio non solo ai giovani ma a tutta la comunità.
Sin dai primi giorni, affiancando la capo progetto Tiziana Meretto, ho avuto la possibilità di incontrare alcuni esponenti delle istituzioni locali e dei centri di formazione. Il mio primo mese in Senegal ha visto un alternarsi continuo di riunioni, tavole rotonde, imprese e governatori che mi hanno permesso di comprendere realmente le difficoltà con le quali un’Ong straniera deve fare i conti per poter, innanzitutto, far conoscere il suo progetto ed eventualmente portarlo avanti con l’appoggio della comunità e delle autorità locali. Fin da subito mi è stata chiara l’importanza dell’approccio iniziale, che qui svolge un ruolo estremamente importante ed è alla base di una possibile futura negoziazione. Perché di questo si tratta: “negoziare” e “contrattare”. Per dimostrare il tuo interesse verso qualcosa devi essere abile nell’arte della negoziazione. Qui è la prassi, i senegalesi ce l’hanno nel sangue e non è facile tener testa alla loro determinazione. Tuttavia, apprezzano i toubab (“bianco” nella lingua wolof, il sostantivo col quale chiamano gli occidentali) che si cimentano nella negoziazione e, se ti dimostri ben disposto e paziente, acconsentiranno a darti ciò che richiedi.
Agosto, tuttavia, non è stato solo un mese di lavoro intenso ma anche un periodo di festa. Agli inizi del mese c’è stata la festa della Tabaski, il capodanno musulmano. Uno degli elementi che ho notato sin da subito con grande stupore è stata la convivenza pacifica e a stretto contatto di due religioni, il cristianesimo e l’islam. Anche se il Senegal è uno stato a maggioranza musulmano, vi è una piccola ma forte presenza cristiana e tra questi due mondi, così lontani e diversi tra loro, vige un solenne rispetto reciproco. Nonostante sia molto comune, al giorno d’oggi, sentire di donne e uomini che muoiono per motivi legati alla fede e alla religione professate, soprattutto in contesti del genere, dove la loro presenza è molto sentita e scandisce le giornate della comunità; qui in Senegal, invece, non ho percepito alcun tipo di astio o divisione, tutta la comunità vive in armonia: le chiese celebrano la messa la domenica mattina e la sera il canto musulmano del richiamo alla preghiera riecheggia nell’aria. Magari, prima o poi, sarà così anche nel resto del mondo.
La mia Tabaski è stata all’insegna della condivisione, nella sua forma più pura e spontanea, ha assunto le sembianze di un grande piatto di carne e verdure dal quale senegalesi e toubab hanno attinto per mangiare.
La stagione delle piogge ha scandito le mie giornate, tra lavoro d’ufficio e tempo libero. Il progetto era agli sgoccioli della prima annualità, quindi la maggior parte delle mie mansioni avevano un unico obiettivo: l’organizzazione del rendiconto. Durante il primo anno di magistrale, uno dei tanti corsi per i quali ho dovuto sostenere un esame finale era proprio quello del Laboratorio di Rendicontazione e Project Cycle Management, un corso pratico ma molto basilare. In Senegal, grazie al VIS e alla figura dell’amministratrice finanziaria Katia Benassi, ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze in merito a questa branca della cooperazione, molto meccanica ma di vitale importanza.
L’esperienza fatta grazie al Charity Work Program è stata formativa e arricchente sotto diversi punti di vista ma più di tutti a livello personale: ho scoperto lati del mio carattere che mi hanno piacevolmente sorpresa, ho imparato a conoscere i miei limiti e spesso a superarli, ho raggiunto una nuova comprensione di me stessa, di ciò che sono e del mondo che mi circonda. Ho visto la povertà, quella vera e straziante, e mi sono posta diverse domande alla maggior parte delle quali tutt’ora non sono riuscita a fornire una risposta pronta e ragionata; forse perché sono ancora in fase di metabolizzazione, di riflessione e analisi o forse perché a certe domande una vera risposta non c’è, giusta o sbagliata che sia, semplicemente non esiste.
In conclusione devo ammettere che non sono tornata in Italia con la stessa testa e lo stesso spirito di quando sono partita, ma d’altronde, chi è mai tornato da un viaggio scoprendosi uguale a com’era partito?
* 23 anni, primo anno del corso di laurea magistrale in Politiche per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, facoltà di Scienze politiche e sociali, campus di Milano