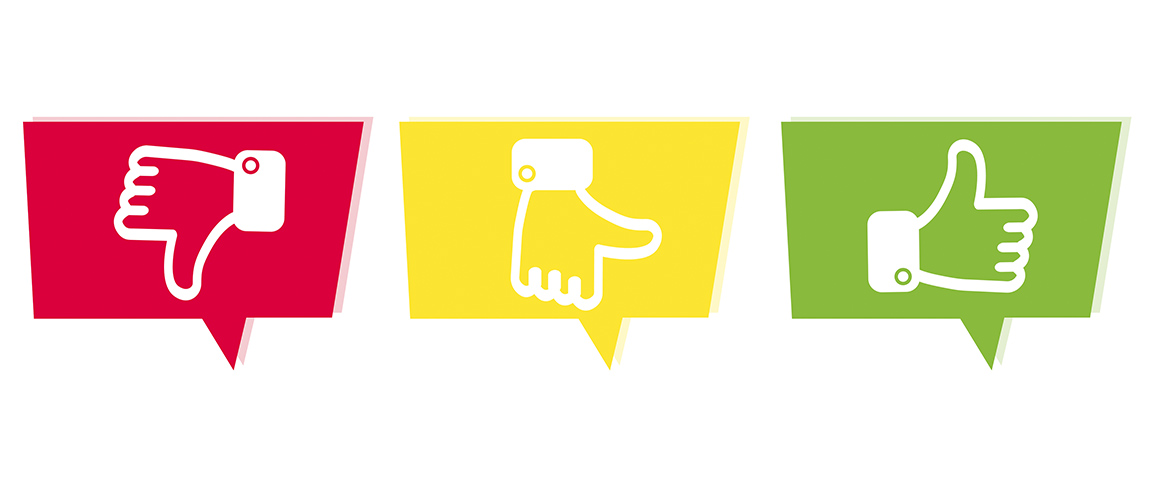di Damiano Palano *
Sono trascorsi ormai quasi otto mesi dalla sera di febbraio in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciò per la prima volta l’adozione di misure straordinarie volte a contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19. In questo tempo ci siamo ormai abituati a vivere nello «stato di emergenza» e – talvolta con un po’ di insofferenza – ci siamo anche adeguati ai dispositivi di protezione e alle norme sul distanziamento sociale.
Seguendo le cifre sull’andamento dei contagi, sul numero dei ricoveri, sulla concentrazione geografica dei focolai, ci siamo chiesti praticamente ogni giorno quando il virus comincerà a perdere la sua forza e quando potremo finalmente salutare la fine della pandemia. Ma forse dovremmo anche iniziare a chiederci come l’esperienza globale della pandemia cambierà il mondo, quali tracce lascerà nel tessuto delle nostre società, e quali conseguenze produrrà sulle nostre democrazie.
Mentre la «seconda ondata» sta iniziando ad abbattersi sull’Europa, si possono ovviamente formulare solo ipotesi molto generiche, ma tutt’altro che rassicuranti, sul futuro che ci attende. I problemi con cui ci troveremo alle prese non saranno molto diversi da quelli che conosciamo da anni, ma saranno ulteriormente esacerbati dalle tensioni che ci lascerà in eredità la pandemia. La depressione economica che si profila all’orizzonte – e che ovviamente dipenderà anche da ciò che accadrà nei prossimi mesi – segnerà quasi certamente un ulteriore aggravamento della «crisi fiscale» dello Stato, che in alcuni casi potrebbe anche offrire spazi consistenti al riemergere della protesta fiscale.
In secondo luogo, la contrazione delle economie occidentali, aggravando le diseguaglianze, potrebbe contribuire a indebolire ulteriormente la fiducia riposta in leader e partiti. Inoltre, le conseguenze del Covid-19 potrebbero accelerare il “declino relativo” dell’Occidente (sotto il profilo economico, politico e culturale), o la stessa la tendenza allo spostamento verso Est del baricentro dell’economia globale.
Tutti questi fattori, amalgamandosi in un cocktail esplosivo, potrebbero andare così fornire nuovo carburante al cultural backlash: una reazione culturale ai processi di globalizzazione e ai valori del “cosmopolitismo” che scaturisce soprattutto dalla sensazione di insicurezza e deprivazione sperimentata da alcuni strati sociali. E, così, quote di elettorato potrebbero spostarsi verso posizioni più radicali, potrebbero polarizzare ulteriormente lo scontro politico, o aggravare il «deconsolidamento» delle democrazie mature.
I risultati di una ricerca condotta nelle scorse settimane da Ipsos su un campione di cittadini italiani sembrerebbero confermare proprio l’ipotesi che sia già in atto un processo di «deconsolidamento» democratico, ossia uno “scollamento” dei cittadini occidentali dai valori democratici su cui si reggono i nostri sistemi politici. Ma il dato più significativo non è forse quello relativo alla percentuale di intervistati che si dichiarano delusi e insoddisfatti rispetto alla democrazia, bensì il basso livello della fiducia riposta nelle istituzioni, nella classe politica, nei partiti. Perché proprio la fiducia nel sistema – e nella sua capacità di rispondere in modo sufficientemente adeguato alla pandemia – potrebbe uscire colpita in modo duro dalla crisi che stiamo vivendo.
Le conseguenze che ci dobbiamo attendere dal futuro sono però probabilmente ancora più profonde di quelle che possono essere rilevate dai sondaggi di opinione, o da quelle che riguardano lo scenario della competizione politica. Nello «stato di emergenza» in cui ci troviamo a vivere, vengono “sospesi” o limitati molti dei diritti delle libertà che eravamo abituati a considerare come costitutivi della democrazia. Ma anche quando ci saremo lasciati alle spalle la fase più critica della crisi sanitaria, è probabile che non cesseremo di vivere nello «stato di emergenza». O, quantomeno, non possiamo escludere che l’esperienza di questi mesi e l’accelerazione che essa sta implicando su molti processi comporteranno modificazioni strutturali sui sistemi politici occidentali e sulla sfera delle nostre libertà.
La convinzione che sia necessario rinunciare a porzioni di libertà per tutelare la sicurezza individuale e collettiva non è certo nuova. Per molti versi è una componente costituiva del progetto moderno, dal momento che lo Stato moderno si legittima storicamente proprio in quanto garante della sicurezza dei propri sudditi. Molte volte l’appello a sacrificare porzioni di libertà in nome della sicurezza è stato inoltre pronunciato per richiamare i cittadini occidentali al dovere di salvaguardare la democrazia, il pluralismo e lo Stato di diritto. Ma l’«emergenza» che richiedeva il sacrificio temporaneo di diritti e libertà era stata fino a ora legata alla necessità di combattere la violenza terroristica, di sconfiggere organizzazioni criminali, di contrastare cioè “nemici” in carne e ossa.
L’«emergenza» che il mondo sperimenta oggi invece non ha un volto, non è riconducibile a nessun nemico in carne e ossa, è legata alla fragilità della condizione contemporanea e all’interdipendenza della società globalizzata. Proprio per questo non si tratta di un’«emergenza» che potremo davvero lasciarci alle spalle. Anche quando il Covid-19 sarà stato debellato, non potremo cioè evitare di monitorare costantemente la marcia di nuovi virus, di sviluppare tecnologie di tracciamento, di intervenire tempestivamente per impedire lo sviluppo di una nuova pandemia, di predisporre apparati in grado di agire in caso di emergenza. Dinanzi a ciascuno di noi potrebbe così ergersi il potere di un Leviatano molto più invasivo di quello immaginato da Thomas Hobbes. E sarà allora davvero necessario ripensare garanzie ed equilibri adeguati alla portata di quella sorta di «stato di emergenza» permanente che probabilmente ci attende.
* direttore del dipartimento di Scienze politiche, docente di Scienza politica e Teoria politica dell’età globale, facoltà di Scienze politiche e sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore