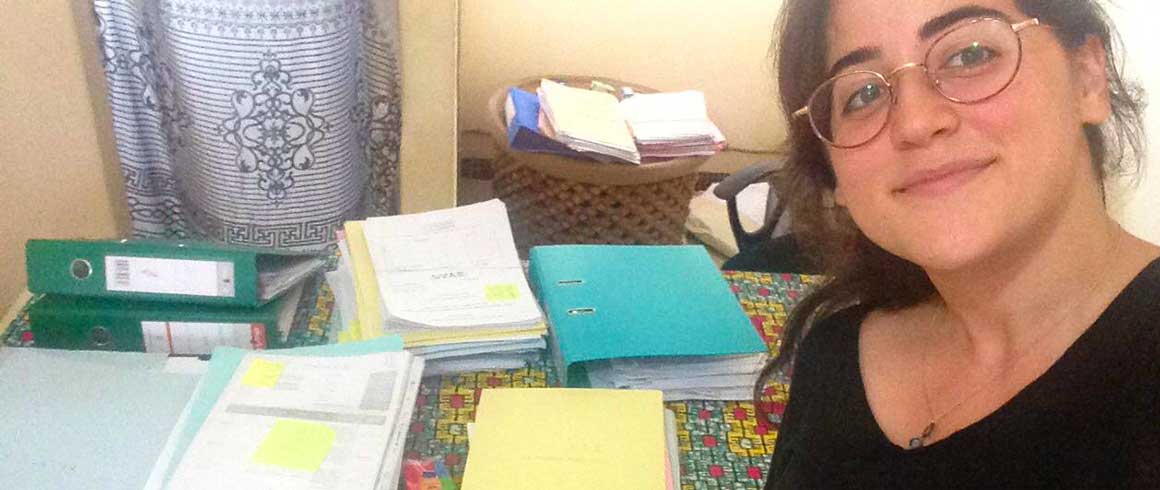di Vincenzo Tarantino *
 “Un mese in Uganda, in Africa, a 5.000 km da casa, non sarà troppo?” Questo l’interrogativo che mi risuona in testa mentre chiudo i bagagli e ultimo i preparativi. Interrogativo che si ripresenta e si insinua come un tarlo nelle conversazioni con i miei compagni di avventura durante il lunghissimo viaggio d’andata. Dall’aereo in atterraggio ad Entebbe solo due colori abbracciano tutto l’orizzonte: il rosso della terra e il blu sconfinato del lago Vittoria che quasi sembra un mare. Terminata la prima parte del viaggio cambiamo mezzo e con il nostro driver ci proiettiamo nel traffico caotico e privo di alcun ordine delle strade di Kampala, brulicanti di persone indaffarate nelle più disparate attività che ricambiano la curiosità negli sguardi di noi “Muzungu” (Muzungu è “l’uomo bianco”, l’appellativo che tutti, bambini specialmente, utilizzeranno per apostrofarci in questo viaggio).
“Un mese in Uganda, in Africa, a 5.000 km da casa, non sarà troppo?” Questo l’interrogativo che mi risuona in testa mentre chiudo i bagagli e ultimo i preparativi. Interrogativo che si ripresenta e si insinua come un tarlo nelle conversazioni con i miei compagni di avventura durante il lunghissimo viaggio d’andata. Dall’aereo in atterraggio ad Entebbe solo due colori abbracciano tutto l’orizzonte: il rosso della terra e il blu sconfinato del lago Vittoria che quasi sembra un mare. Terminata la prima parte del viaggio cambiamo mezzo e con il nostro driver ci proiettiamo nel traffico caotico e privo di alcun ordine delle strade di Kampala, brulicanti di persone indaffarate nelle più disparate attività che ricambiano la curiosità negli sguardi di noi “Muzungu” (Muzungu è “l’uomo bianco”, l’appellativo che tutti, bambini specialmente, utilizzeranno per apostrofarci in questo viaggio).
Bastano poche ore al Benedict Medical Centre per rispondere all’interrogativo iniziale: un mese basterà appena per far nostro tutto quello che questa magnifica esperienza ha da offrire.
L’Uganda è un paese ricco di colori, cultura, tradizioni, dolore per la storia tormentata, coraggio e speranza per il futuro, spiritualità, usanze, ma soprattutto dissidi spesso inaccettabili agli occhi e al metro di giudizio di noi Occidentali.
Il Benedict si rivela una palestra intensiva che mette a dura prova quanto imparato negli anni di lezione e tirocinio in Italia: il personale dell’ospedale, dai medici agli infermieri, ci include nel team, ci interpella per le decisioni diagnostiche e terapeutiche e per la prima volta da semplici studenti diventiamo un po’ medici. Ho la possibilità di mettermi alla prova, partecipare al processo di cura, toccare con mano, confrontandomi con una medicina umana, intima, fisica e emotiva nel contatto con il paziente, molto diversa per situazioni ed emozioni da quella di casa a volte impersonale e spogliata della componente umana.
Impossibile raccontare questa esperienza senza menzionare il grande gruppo di volontari che riunita intorno al tavolo della Mission House del compianto padre John Scalabrini, fondatore dell’ospedale e delle attigue scuole, ha allietato tutti i pasti con racconti, esperienze e riflessioni diventando a poco a poco una vera famiglia.
Le emozioni che porterò per sempre con me sono senza dubbio quelle provate partecipando per la prima volta ad una nuova nascita, la gratitudine che i pazienti mostravano a ogni minima attenzione di noi operatori e soprattutto lo sguardo e le risate dei bambini felici di ogni piccolo momento passato a giocare con loro.
Partito con l’idea di dare il mio contributo, offrire le mie (scarse) competenze, aiutare; ho finito per ricevere, imparare, prendere. Arrivato da estraneo, lascio questa terra grato a tutte le persone che ho incontrato per il calore ricevuto e per i mille stimoli di riflessione e con in valigia e nel cuore una grande voglia di ritornare. Tutti ci hanno salutato chiedendoci “when will we see you again?”. Presto.
* 23 anni, di Frattamaggiore (Na), studente del quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, campus di Roma