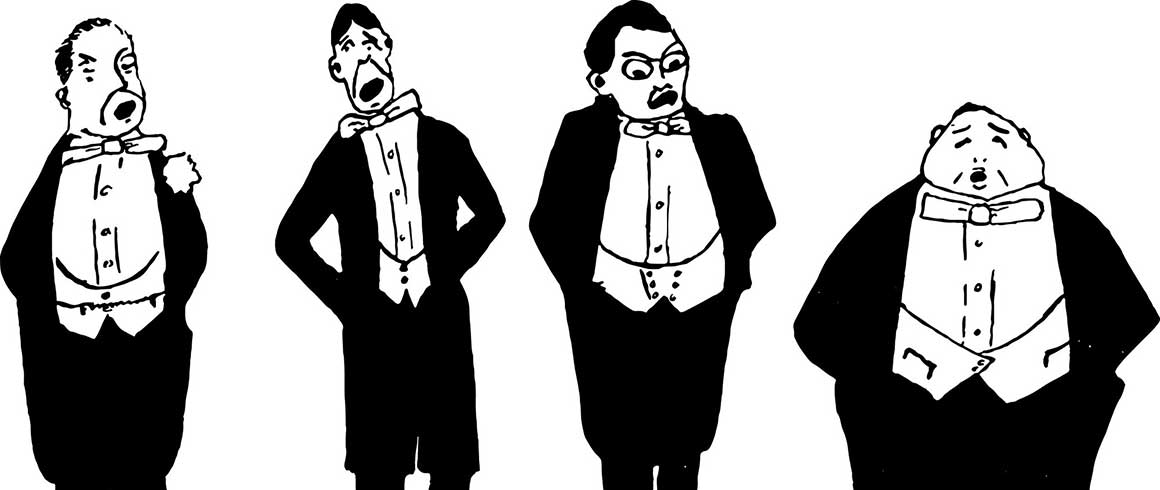“Chierici, cortigiani, battitori liberi. Quale ruolo per gli intellettuali?” è il titolo del convegno promosso dal centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” il 30 ottobre a Milano. In quell’occasione il professor Giuseppe Lupo ha lanciato un dibattito a cui hanno aderito alcuni docenti della Cattolica. Quella che pubblichiamo (Trahison des Clercs) è la celebre lettera scritta molti anni fa da un vescovo, monsignor Antonio Bello, agli intellettuali della sua città.
di don Tonino Bello *
Cari intellettuali, se do a questa lettera un titolo esotico, la ragione è duplice. Anzitutto, perché i poveri (voglio dire gli abituali lettori di questo foglio), vedendo in cima una misteriosa frase francese, passeranno oltre, non leggeranno il “pezzo”, e voi potrete così salvarvi la faccia, almeno davanti a loro. In secondo luogo, perché, scegliendo una frase volutamente ambigua, pago in anticipo l’insolenza di incriminarvi di tradimento col prezzo di far fraintendere, a più d’uno, che “clercs” significhi chierici come uomini di Chiesa, e non chierici come uomini di cultura.
Un modo forse ingenuo per farmi perdonare il mio “j’accuse” contro di voi, visto che, almeno sul piano lessicale, accenno a una certa spartizione di responsabilità in fatto di tradimento. Spartizione, che poi è anche giusta. Non sono tanto digiuno di storia, passata e recente, da ignorare i tradimenti consumati dalla Chiesa contro di voi, i suoi sospetti sul vostro modo di inseguire la verità, le sue paure sulla vostra autonomia intellettuale, le sue preoccupazioni sul vostro modo di intendere la libertà, la sua durezza nel recepire non solo i vostri metodi di ricerca ma anche la lettura da voi data delle realtà terrestri. A un certo punto vi “ha mollati” (verbo volgarissimo corrispondente al latino “tràdere”), e ora sconta pesantemente la pena di un recupero che diventa sempre più difficile.
Io, però, voglio oggi parlarvi del vostro tradimento. E non di quello da voi messo in atto come ritorsione nei confronti della Chiesa, ma di quello ben più grave da voi operato nei confronti della città. Ci state lasciando soli. Vi siete ritirati nelle vostre torri d’avorio, non si sa bene se a meditare vendetta, o a ruminare sterili supplementi di analisi, o a contemplare dalle vostre aride specole i fasti di una dietrologia senza speranza. Siete latitanti dall’agorà. È più facile trovarvi nelle gallerie che nei luoghi dove si esprime l’impeto partecipativo che costruisce il futuro. State disertando la strada. Per scarnificare la storia di ieri, state abbandonando la cronaca di oggi che, senza di voi, è destinata a diventare solo cronaca nera.
Sul vostro labbro si coglie uno sconcertante abuso di ironia, che mentre esprime lucidità di memoria, appanna la lucidità dei progetti. Manca nel vostro linguaggio quel sarcasmo appassionato che è indice di solidarietà con la storia degli uomini. Vi siete staccati dal popolo, così che, per la vostra diserzione, stanno cedendo nell’organismo dei poveri anche quelle difese immunologiche che li hanno preservati finora dalle più tragiche epidemie morali. Vittime del privatismo, il male oscuro del secolo che voi per vocazione avreste dovuto debellare, avete abbandonato i laboratori della sintesi dove la poesia si mescola col giornale, il sogno con la realtà, la tensione assiologica con le fredde esigenze della tecnica, gli spartiti musicali della vita con gli arrangiamenti banali dei rumori quotidiani. E intanto la città muore. Col vostro nulla osta.
La città benestante, consapevole dei suoi mezzi ma cieca nei suoi fini, corre verso un degrado di felicità mai conosciuto finora; mentre la città diseredata vive in simbiosi con la disperazione più nera e langue per asfissia da futuro. Cari amici, non sto prendendo in prestito nulla dalla letteratura apocalittica corrente, né mi va di fare del moralismo di maniera. Anzi se c’è qualcosa che mi ripugna come Vescovo è quello di essere considerato funzionario del buon costume. Ma non posso chiudere gli occhi di fronte alle situazioni pesantissime di miseria, di disoccupazione, di violenza, di ingiustizia, di violazione dei diritti umani, di affossamento dei valori, di degenerazione della qualità della vita e di cento altri fenomeni patologici, di fronte ai quali viene chiamata in causa la vostra correità di intellettuali che, pur essendo vestali della luce e sentinelle della città, scorgete la barbarie andare in metastasi nel tessuto della nostra convivenza e continuate a star zitti. Ci state lasciando soli a tamponare emorragie e a fasciare piaghe sulle trincee.
E anche quando sembrate gratificarci col dire che stiamo combattendo battaglie d’avanguardia, sotto sotto ci pare di leggere nei vostri giudizi il compatimento per chi si sta solo estenuando in scaramucce di retrovia. Cari amici, perdonatemi lo sfogo. Se un chierico come me, più propenso per antiche deformazioni ad attaccare vizi privati e a blandire pubbliche virtù, stavolta ha sentito il bisogno di aggredire i vizi pubblici di chierici come voi, è perché sa di poter fare affidamento sulle vostre tantissime virtù private. Tra queste mi pare che ancora ci sia la speranza. E allora, da essa guidati per mano, intraprendiamo insieme la strada dell’esodo. Che è la strada della misericordia. Divenuti pellegrini, usciremo sulla Gerusalemme-Gerico. Forse insieme riscatteremo la freddezza del sacerdote, chierico del sacro, e l’apatia del levita, chierico del sapere. Insieme, fatti prossimo, ridaremo la mezza vita all’uomo mezzo morto boccheggiante sulla strada. E le stelle non staranno più a guardare, come nei romanzi di Cronin. Vi voglio bene.
* vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi (1935-1993), la lettera agli intellettuali fu pubblicata il 25 gennaio 1987 sul Settimanale diocesano “Luce e vita”
Undicesimo contributo di una serie di articoli dedicati al ruolo degli intellettuali